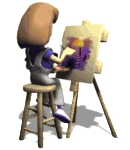di Cristina De Angelis
Con il termine handicap si intende “diversità irreversibile, presenza di un deficit psicofisico o mentale tale da condizionare l’autonomia, la capacità relazionale, lo sviluppo e le funzioni conoscitive.”
La scuola si trova in molti casi in difficoltà per gestire queste situazioni.
I docenti della scuola dell’infanzia devono organizzarsi per l’inserimento e l’integrazione del bambino disabile nel gruppo classe.
Importante è utilizzare tutte le risorse disponibili sia in ambito scolastico sia in quello extra-scolastico cercando di fissare come obiettivo l’autonomia fisica e fisiologica, comunicativa, sociale, motoria e cognitiva.
L’analisi sistematica e il quadro analitico dei livelli funzionali del bambino diversamente abile sono molto importanti per elaborare un itinerario di rinforzo adeguato ed individualizzato scegliendo tecniche educative appropriate.
Sono utilizzate spesso la psicomotricità , la musicoterapia, laboratori manipolativi, laboratori visivi,il gioco, l’uso di materiali strutturati, il suono, il canto, la drammatizzazione che possiamo considerare non solo strategie socializzanti ma anche ordinatrici delle risorse psicofisiche , mentali e relazionali.
L’integrazione scolastica dei bambini diversamente abili non è un problema solo dei docenti o dell’educatrice ma occorre tirare in campo la scuola , la famiglia e i servizi sociali per creare un dialogo costruttivo e positivo per il bambino.
Deriva perciò un dialogo aperto tra la componente scolastica, l’èquipe sociopsicosanitaria e la famiglia. La scuola ha come fine l’inserimento e l’integrazione del bambino con handicap ma occorre ricordare che serve una cooperazione concreta effettiva e costante tra gli enti, i responsabili dei servizi creando un’azione educativa positiva e costruttiva e soprattutto per costruire le basi della personalità del bambino il quale, sentendosi sicuro, aiutato e stimolato, possa superare le difficoltà che incontrerà sia a scuola sia nel percorso della sua vita.
E’ infatti necessario che i ragazzi disabili in età scolare siano messi in grado di interagire con i coetanei normodotati, i quali a loro volta impareranno a comunicare ed a porsi in relazione con i ragazzi con disabilità. Il miglior mezzo per l’attuazione sistematica di un programma di integrazione sociale è la definizione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che rappresenta un reale piano operativo predisposto a misura dei bisogni e degli obiettivi individuali del bambino con handicap e va pertanto utilizzato anche ad identificare i principali obiettivi di integrazione sociale.
Questo processo devono riflettere anche i bisogni dei genitori e le loro possibilità di aiuto continuativo al programma.
Importanti ,in questo momento post- inserimento, sono il monitoraggio e la registrazione dei progressi nonché l’attività di rinforzo necessarie. Non sarà tuttavia sufficiente identificare gli obiettivi appropriati per un programma di integrazione sociale, localizzare i contesti più adatti ed applicare le varie strategie d’intervento.
I problemi più frequenti che possono provocare problemi al raggiungimento degli obiettivi possono essere il monitoraggio difficile, il contesto d’apprendimento non pronto, le reazioni dei genitori e familiari poco interessati o limitati.
Parlare di prevenzione, diagnosi precoce e assistenza anche se si è chiamata advocacy(movimento di aiuto specifico) è un argomento vasto e difficile. Importante perciò è parlare dei tratti medici e psicologici ma che quelli didattici che curano l’inserimento non basando il problema sono come aspetto medico e normativo. L’aspetto normativo e sociale dell’handicap è un problema che bisogna conoscere e attuando programmi per la salute di tutti sia quella fisica sia psicologica.
Il concetto di Integrazione può dunque essere articolato a vari livelli:
• integrazione fisica,
• funzionale,
• sociale,
• personale,
• sociale,
• dei servizi.
La conoscenza dell’alunno con handicap si muove attraverso diverse fasi, prima di tutto attraverso la Diagnosi funzionale cioè la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico,di cui ha competenza l’unità multidisciplinare costituita presso l’Azienda Sanitaria locale composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dal neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione e dall’assistente sociale, i docenti curricolari e di sostegno, unitamente ai familiari dell’alunno concorrono ad arricchire e completare l’accertamento specialistico. Si evidenziano le potenzialità, gli aspetti cognitivo – affettivo/relazionali – linguistico – sensoriali – motorio/prassico – neuropsicologico – autonomia, si aggiungono elementi di osservazione anche in ordine all’asse di apprendimento al fine di delineare il profilo dinamico funzionale che completa il quadro di conoscenza – analisi della situazione e indica il prevedibile livello di sviluppo in tempi brevi e medi.
Alla fase di conoscenza segue quella operativa di descrizione degli interventi che concorrono a delineare il Piano Educativo Individualizzato riferito alla disabilità, alle difficoltà conseguenti e alle potenzialità dell’alunno portatore d’handicap.
L’integrazione nella scuola e oltre la scuola come nella famiglia, nella società e poi nel mondo del lavoro richiede di essere considerata in maniera contestualizzata poiché è la persona la centro dell’attenzione.
Alla cultura della prevenzione, deve accompagnarsi la cultura dell’azione da parte dei singoli e della collettività secondo specifici ruoli e funzioni In Italia la normativa riguardante l’integrazione dei portatori di handicap, in questi ultimi anni, si è moltiplicata portando così un ampio quadro normativo avanzato presupponendo scelte culturali, sociali e politiche nella coscienza politica. Gli inabili e i minorati hanno diritto all’istruzione e all’avviamento professionale art.38 comma 2 della Costituzione Italiana.
Penso che questo possa essere un punto di partenza e ci possa aiutare a riflettere .
Riferimenti normativi
Costituzione della Repubblica Italiana, Milano, Alberto Peruzzo Editore, 1993
Legge n. 833 del 23/12/1978, Istituzione del servizio sanitario nazionale.
D.P.R. 104 del 12/5/1985, Programma didattici della scuola primaria.
Legge n. 104 del 5/2/1992, Legge–quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone Handicappate
D.P.R. del 24/2/1994, Compiti delle UU.SS.LL. – Diagnosi funzionale.Profilo dinamico funzionale. Piano educativo individualizzato.
BibliografiaAvalle U.; Cassola V., Scuola e Educazione degli Anni Novanta: Realtà e Prospettive. Torino, Paravia Editore, 1993
Canavaro A.; Balzaretti C.; Rigon G., Pedagogia Speciale dell’Integrazione – Handicap: conoscere e accompagnare. Firenze, La Nuova Italia, 1997
Luchetti M.
Didattica e cultura dell’integrazione: handicap: una rivoluzione copernicana nella società e nella scuola
Roma, Editore La Goliardica, 1985
Vianello R.
Psicologia Sviluppo Educazione
Firenze, Juvelia, 1998
Della stessa autrice di questo articolo:
Educazione e grafismo
"Gli alunni portatori di handicap: finalità e problemi educativi ed organizzativi relativi alla loro integrazione scolastica, sociale e lavorativa"
Tesi di Laurea in Scienze dell'Educazione - Università di Roma Tre,
A.A. 2002/2003.
Scegli un'altra sottosezione:

|